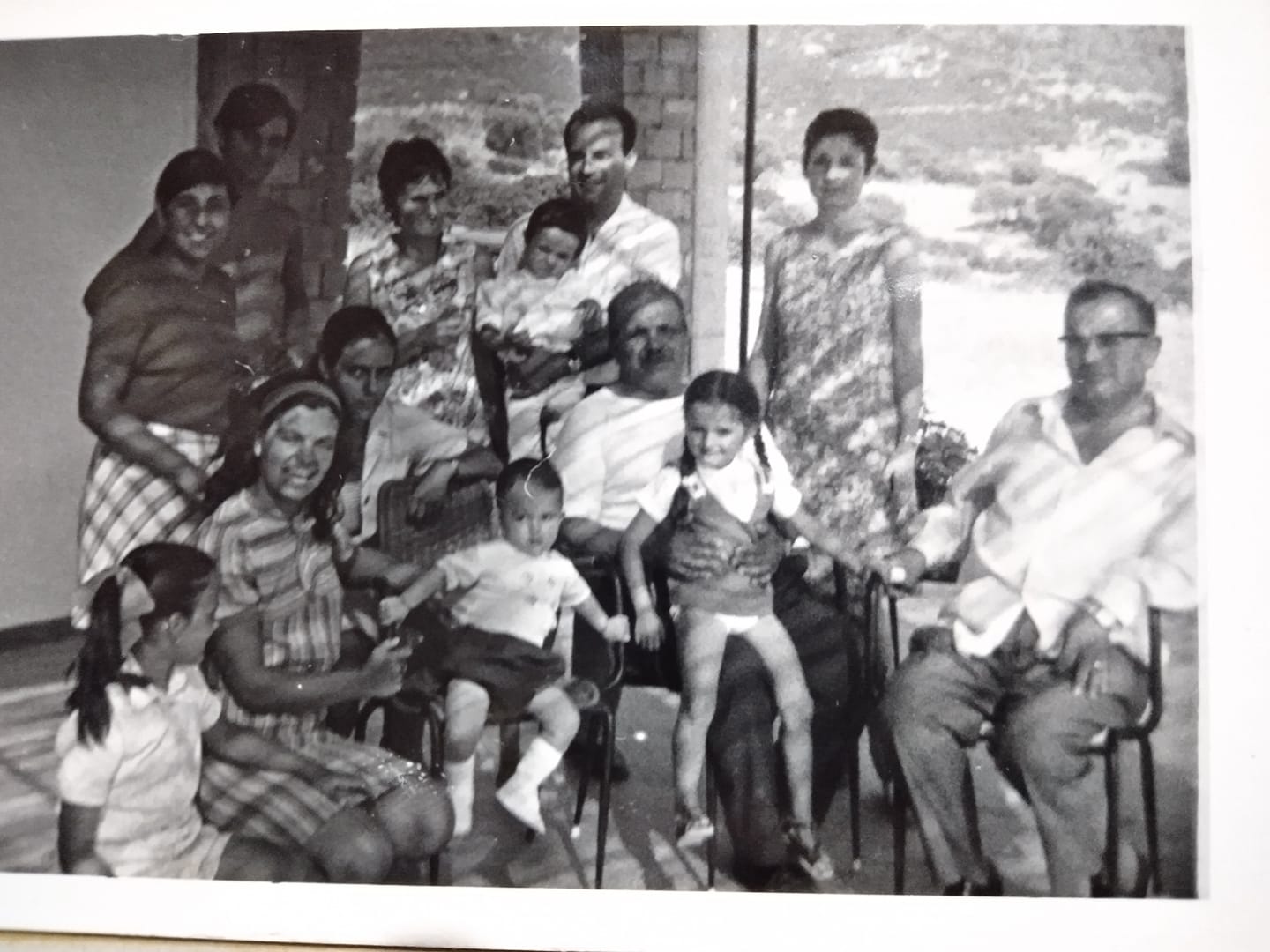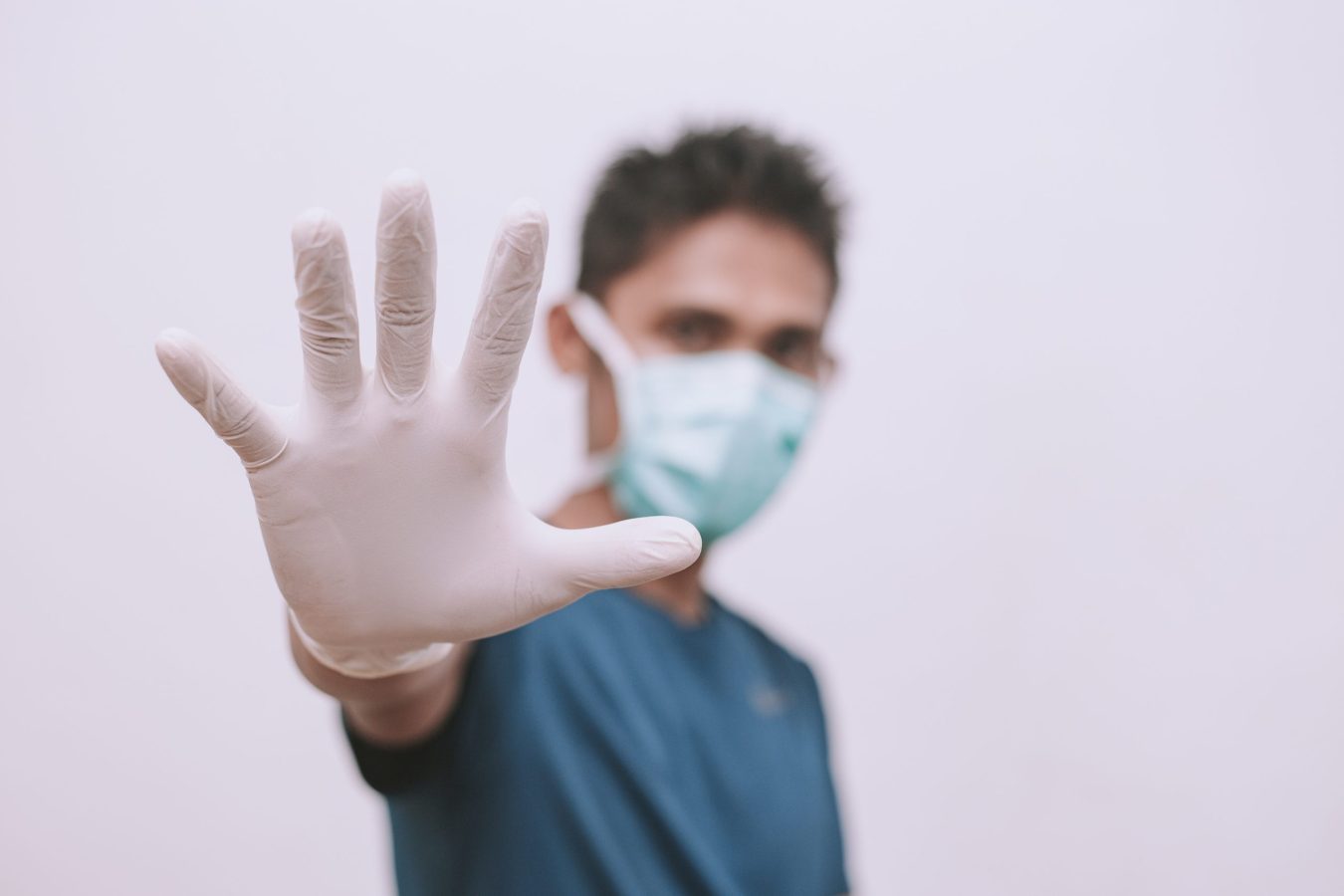Che la Sardegna sia uno scrigno misterioso e ricco di affascinanti tradizioni ancestrali è cosa ormai nota. Simboli e particolari rituali, qui, sono sorti al principio della storia dell’uomo, nati per propiziarsi antiche divinità e per celebrare ricorrenze che, con il sacro dei tempi moderni, hanno poco a che fare. Vecchi di millenni, tali elementi si ritrovano ancora oggi; si presentano sotto celate vesti, plasmati da altre culture e farciti di nuovi significati, ma, non dimentichi, conservano intatto il fascino dell’antico passato, quando ancora la sacralità era dominio della natura. Questo è il caso de “Su Nènniri”, una delle tradizioni pasquali più diffuse nell’Isola, una pratica sacra in cui pulsa, però, un cuore pagano. Dalla costa ai borghi dell’entroterra, “Su Nènniri”, insieme a palme e ramoscelli d’ulivo, è parte integrante del pacchetto delle tradizioni pasquali isolane e non vi è chiesa che non ne contenga uno. Candidi germogli di grano svettano da un vasetto ornato con fiori e nastri, per adornare “su Sepulcru”, il sepolcro del Cristo, durante il Giovedì Santo: dei veri e propri “giardini”, simbolo cristiano della morte e della risurrezione, che nascono al buio, sotto un soffice velo di ovatta, per poi appassire velocemente, alla luce del sole.
La tradizione
“Su Nènniri” è un piccolo vaso colmo di terra e bambagia che – secondo l’antica tradizione cristiana – si preparava al principio del periodo di Quaresima, solitamente durante il Mercoledì delle Ceneri: un compito che spettava principalmente alle donne. Seminato con chicchi di grano, misti ad orzo e semi di lino, il vasetto veniva poi ricoperto da uno strato di cotone e nascosto in un luogo caldo, lontano dalla luce: sotto il letto o dentro a un armadio, la semina riposava al buio, costantemente innaffiata, per diverse settimane e i germogli, in virtù della privazione della luce solare, crescevano pallidi, assumendo un colore bianco o giallastro. Giunto il Giovedì Santo, “Su Nènniri” veniva poi portato in chiesa e, una volta secco, il pallido fogliame andava bruciato per evitare che venisse profanato: in antichità, i germogli venivano conservati con cura e impiegati per “is affumentus” (le fumigazioni), considerati un toccasana per molti mali.

I pallidi germogli de Su Nènniri – Fonte www.lulivetosulcanalbianco.blogspot.it
Ancora oggi, la tradizione de “Su Nènniri” è forte e vive nella cultura cristiana dell’Isola, ma, in realtà, quei pallidi germogli di grano hanno radici ben più lontane che si innestano in un terreno squisitamente pagano. Bagaglio di un ancestrale rituale propiziatorio comune a molti popoli dell’area mediterranea, “Su Nènniri” rimanda direttamente al culto dei giardini di Adone, il dio greco della vegetazione che nasce in primavera, portando abbondanza, e muore sul finire dell’estate. Secondo il mito, Adone era conteso da Persefone e Afrodite, preferendo la seconda alla prima e scatenando le ire di quest’ultima. Per decisione di Zeus, il dio conteso dovette dividere il suo tempo tra le due contendenti: la prima metà dell’anno nel regno degli inferi, in compagnia di Persefone, mentre la seconda la passava sulla Terra, in compagnia di Afrodite, continuando a incarnare il ciclo stagionale della natura. Ancor prima di essere greco, tale mito, in realtà, proviene dal mondo mesopotamico e si riflette nel dio Tammuz, divinità agraria simbolo della forza rigeneratrice della natura, che ogni anno discendeva negli inferi per poi risorgere durante il periodo primaverile.
Celebrato in Grecia e in Asia minore – dove tutt’oggi è ancora vivo – il culto dei giardini di Adone arrivò, poi, in Sardegna, mantenendo intatto, almeno prima dell’avvento del Cristianesimo, il suo originario significato: morte e rinascita del dio della vegetazione segnano e celebrano il passaggio dal buio invernale alla luce primaverile, periodo in cui la terra è nuovamente feconda e, generosa, dona i suoi frutti. Per celebrare questo passaggio, il rito in onore di Adone prevedeva la realizzazione di vasi colmi di germogli di cereali e di ortaggi che crescevano e appassivano molto velocemente, metafora della breve vita della divinità, nonché del ciclo perpetuo della natura. I semi, come la divinità, dovevano trascorrere un lungo periodo di tempo lontano dalla luce del sole, il primo negli inferi, i secondi nella terra, e solo quando il clima era propizio, potevano finalmente rinascere.

La tradizione pasquale de Su Nènniri – Fonte www.chiesasarda.it
Come per l’attuale tradizione pasquale de “Su Nènniri”, il compito di preparare e curare i futuri germogli era una prerogativa delle donne. Coltivati in pieno inverno, i vasetti germogliavano proprio con l’arrivo della stagione primaverile: essi erano simbolo della vita di Adone e, al tempo stesso, oggetti sacrificati in suo onore per propiziare la sua successiva rinascita. Sempre le donne, inoltre, piangevano la morte della divinità, rappresentata dai germogli ormai appassiti, che venivano gettati lungo il corso dei fiumi o nelle sorgenti al fine di fecondare le acque e portare fertilità alla terra: nell’Isola erano le sacerdotesse deputate al culto dell’acqua a inscenare la morte del divino, cui seguiva il pianto delle prefiche, le pie donne.
Fino alla prima metà del secolo scorso, un rituale simile si svolgeva a Samugheo, un paesino in provincia di Oristano: in occasione della festa dell’Assunta, le giovinette del paese inscenavano il matrimonio della divinità con una di loro, piangevano la sua morte e festeggiavano, infine, la sua risurrezione. Era la sposa a preparare il vaso dei germogli di grano e a condurlo, con corteo al seguito, fino ad un precipizio, dal quale, poi, veniva gettato. Dopo il pianto, infine, si festeggiava la sua rinascita con la messa e la processione dell’Assunta.

Bari Sardo, sagra de Su Nènniri – Fonte www.sardegnaeventi24.it
Oggi, “Su Nènniri” è soprattutto un simbolo pasquale: specie nel Cagliaritano, il vasetto è anche un dono per amici e parenti in segno di prosperità e imbandisce la tavola durante il pranzo pasquale. In altre zone del Campidano e in Ogliastra, invece, “Su Nènniri” si prepara a fine maggio e viene raccolto un mese dopo per sfruttare i poteri “magici”, acquisiti con la seminagione fino al solstizio d’estate. A Bari Sardo, infine, la seconda domenica di luglio si celebra una vera e propria sagra de “Su Nènniri” che coincide con la festa di San Giovanni: i vasetti accompagnano la processione per il Santo e, benedetti, vengono poi gettati in mare in segno propiziatorio.
Non più passaggio dall’inverno alla primavera, non più sacrificio del dio della vegetazione. Spogliato dal suo carattere pagano, “Su Nènniri” acquista, quindi, il significato cristiano: morte e risurrezione del Cristo, trionfo di gioia e salvezza, ma la tradizione dei vasetti di grano conserva, intatto, il fascino dell’antico passato, simboleggiando, anche se in chiave diversa, la vittoria della luce sulle tenebre.
L’articolo Su Nènniri, la sacra tradizione pasquale dal cuore pagano proviene da ogliastra.vistanet.it.