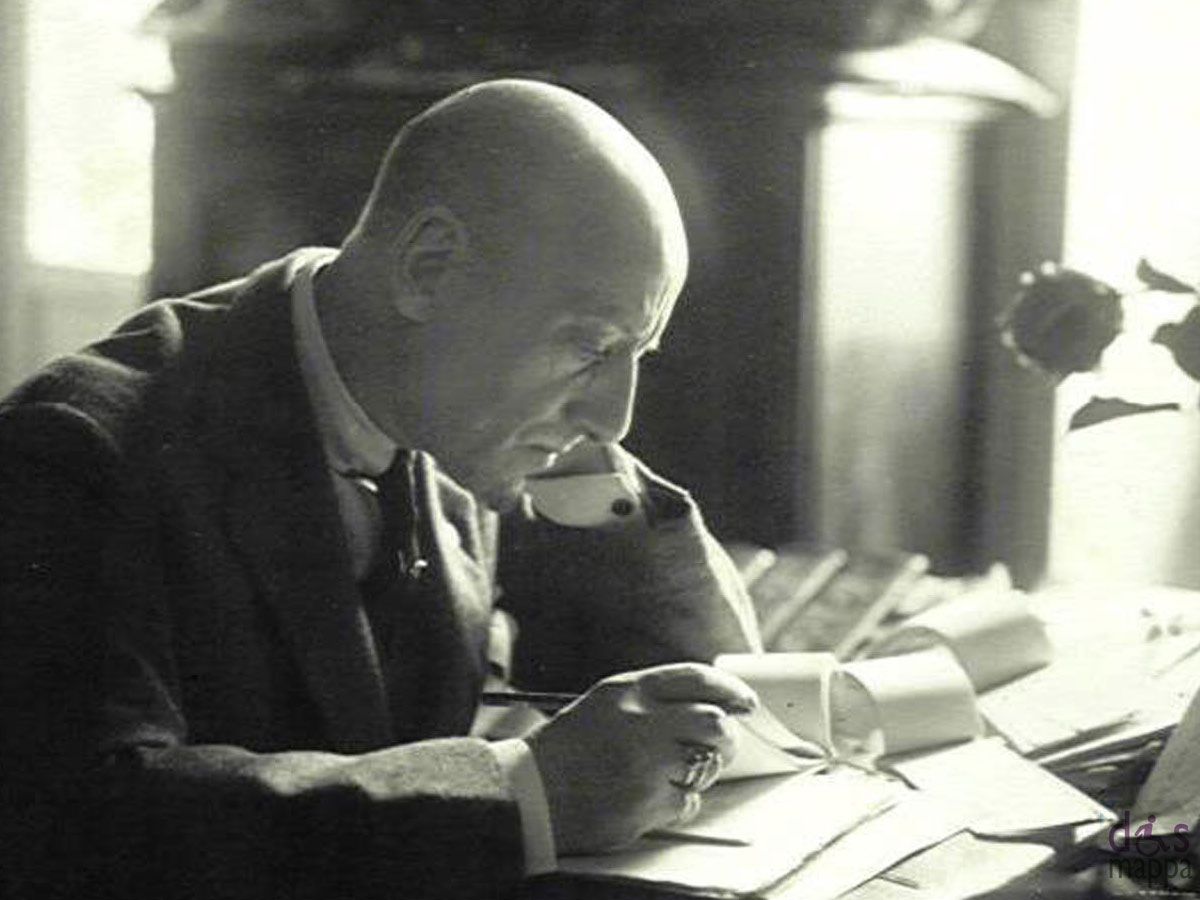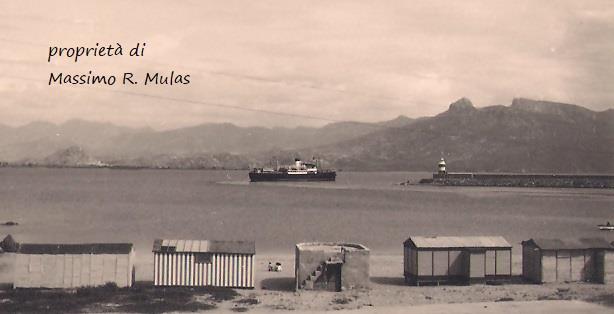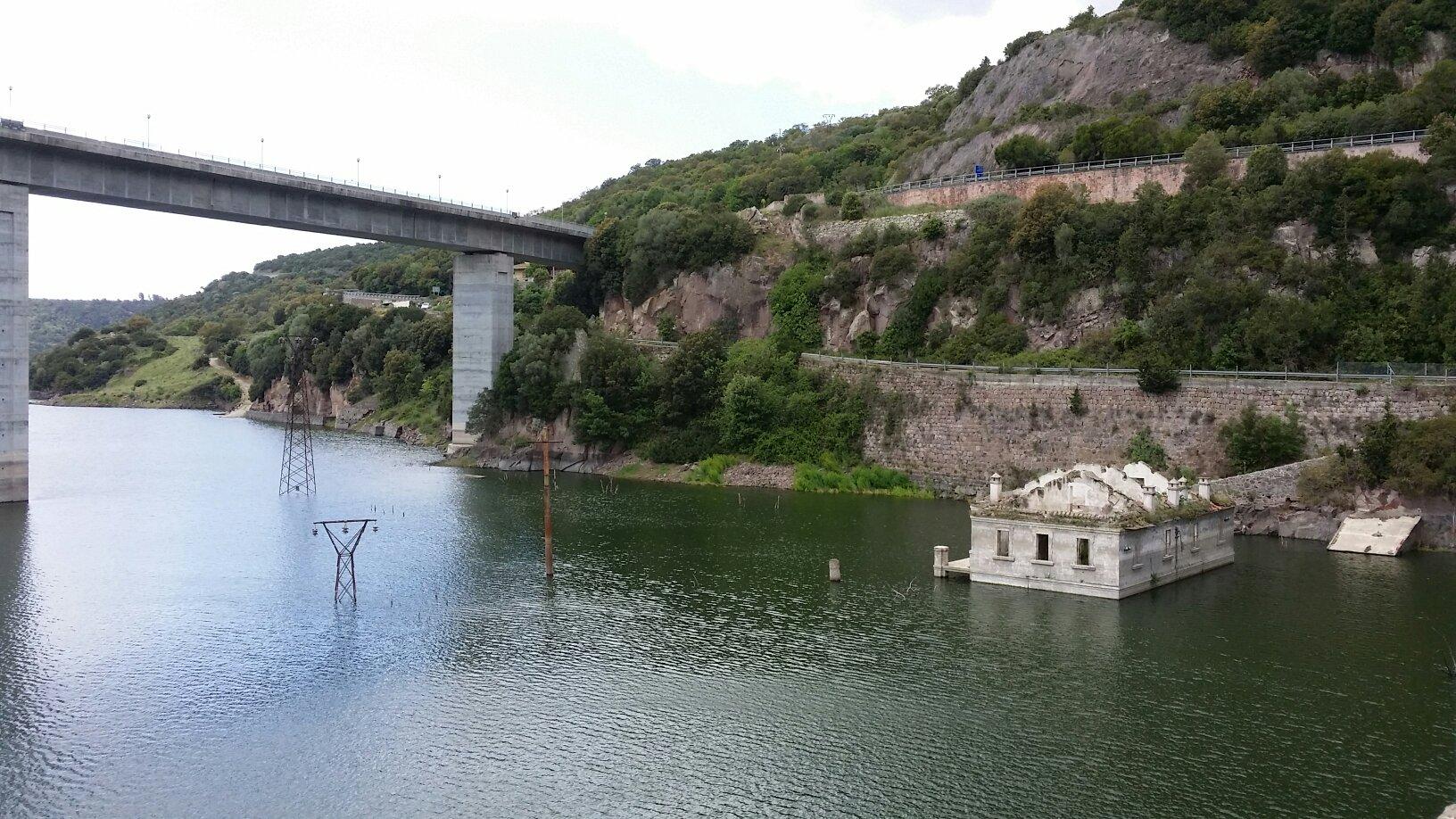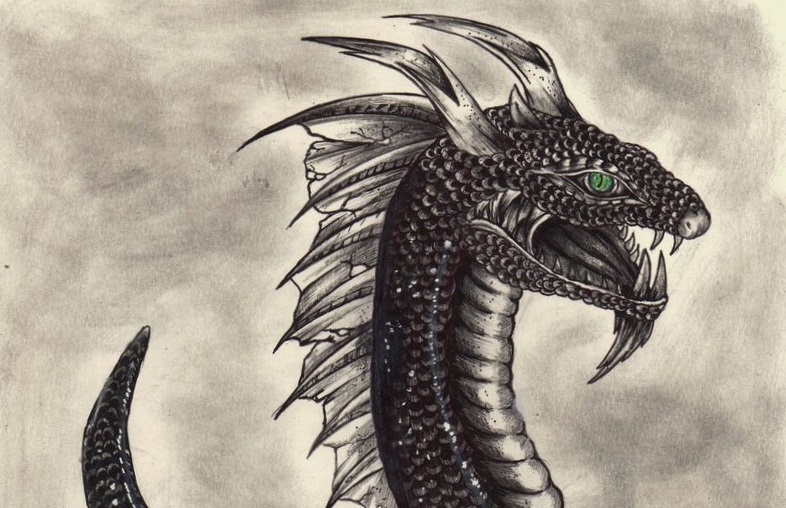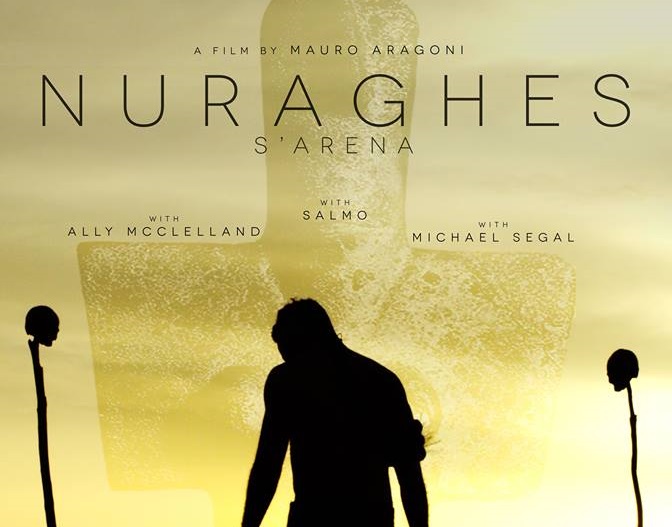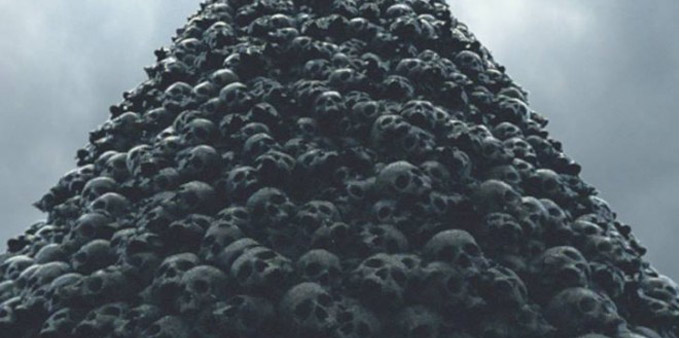A cura di Massimiliano Perlato
Alimento base delle culture povere, il pane, oltre a nutrire la famiglia, diventava anche protagonista delle feste e delle ricorrenze, cambiando forma e consistenza a seconda dell’occasione. C’era così un pane per la nascita e un pane per la morte, molti per il matrimonio e uno per le date significative del calendario.
Il pane ha così sempre accompagnato l’uomo nel corso della sua storia e con lui ha seguito momenti di evoluzione e di crisi. Per quello che riguarda il pane per il consumo quotidiano, secondo una prima, seppur molto ampia e per nulla esaustiva classificazione, vengono di norma individuate in Sardegna tre aree dove, pur in compresenza di altri tipi di pane, vi è una certa prevalenza di uno di questi.
In una di queste prevale la cosiddetta “spianata”, un pane piatto tondo e morbido, non destinato ad essere inzuppato. In un’altra prevale il pane “carrasau”, un pane tondo e piatto anch’esso, ma croccante e a lunga conservazione, destinato ai lunghi periodi trascorsi lontano da casa. In altre aree prevale un pane con “mollica”, grosso, più o meno alto (in qualche caso assomiglia al panettone), che si accompagna bene con qualsiasi tipo di companatico, ma che trova il suo impiego ideale nelle zuppe.
Fra tutti, il pane con mollica era quello di minor durata, una settimana massimo prima che si indurisse. Di qui l’usanza, un tempo diffusa in molti centri sardi, dello scambio del pane fresco, per cui nella cerchia familiare si panificava a turno e si portava il pane agli altri appartenenti al gruppo, con un alto significato di legame e solidarietà. Né, comunque, ci si disfaceva del pane secco, che invece veniva utilizzato per la preparazione di piatti poveri che alla fine risultavano fra i più saporiti. Basti pensare a “su pane addidu” (il pane bollito nel brodo di pecora), o alla zuppa gallurese.
La panificazione dei sardi, però, non si esauriva con i tre tipi di pane citati. Ve n’erano molti altri che, pur svolgendo una funzione meno decisiva riguardo l’alimentazione quotidiana, avevano comunque un ruolo o sempre legato alla tavola, oppure alle occasioni speciali di cui si è detto. Tale è, ad esempio, quello che in Sardegna assume diverse denominazioni a seconda della zona di provenienza, e che può essere chiamato, in generale, la pasta dura. E la pasta dura, sia nella sua versione più grossa “zichi russu” nel Mejlogu, sia in quella sottile (zichi fine), era di solito il pane su cui si esercitava la fantasia e l’abilità delle donne sarde per ottenere le forme e i disegni cui sarebbe stato affidato il compito di celebrare le occasioni speciali.
Si pensi, ad esempio, ai pani nuziali, che in molti casi, per elaborazione e complessità dei disegni, assurgono a vere e proprie opere d’arte. Ma si pensi anche ai pani delle ricorrenze, “su pane ’e Pasca”, per citare quello che forse è il più noto e il più diffuso in tutte le aree della Sardegna, elaborato e ritorto dalla massaia, fino a ricavarne le più diverse forme che la fantasia riuscisse sul momento a partorire. Il pane di Pasqua includeva, di norma, un uovo intero col guscio, che diventava sodo con la cottura in forno insieme al pane. I diversi tipi di pane implicavano, naturalmente, l’uso di diverse varietà di farine, più o meno raffinate, la cui base era sempre il grano duro.
La farina più nobile, non a caso utilizzata, oltre, che per il pane quotidiano (da chi se lo poteva permettere), per il pane delle feste, era “sa simula”, la semola, ottenuta con diversi gradi di raffinazione, in base al crivello (chiliru) o al setaccio (sesattu, sedattu) utilizzati. L’altra farina era “su poddine”, il fior di farina, molto più sottile della semola, e utilizzata di solito mischiata ad essa o al cruschello, per evitare di ottenere dei pani duri come mattoni. Il terzo tipo di farina, infine, quella meno raffinata, con un’alta percentuale di crusca, era “su chivalzu” o “chivarju”. In alcuni casi, però, le famiglie più povere, o anche quelle ricche, quando panificavano per i loro pastori o lavoranti, utilizzavano la farina d’orzo, da cui si otteneva un pane molto saporito, ma di qualità più scadente. Ancor meno pregiata era la panificazione, limitata per quello che se ne sa a ristrette zone dell’isola e a classi veramente povere, con la farina di ghiande.
Numerosi sono i pani cosiddetti comuni che variano per qualità di farina, foggia e nome secondo le zone. Il “pan ‘e trigu” (di grano) si consuma soprattutto nelle aree di ponente, il “pan ‘e trigu-india” (di mais) è tipico del Logudoro come il “cola cola” di farina bianca e fine, “l’orzatu” (di orzo) dal gusto un po’ acidulo è diffuso in Barbagia. Meno frequenti, i pani di patate, di meliga, persino di ghiande che, bollite, pestate nel mortaio e mischiate con argilla rossa e cenere, lasciano nella pasta striature color cioccolato e un sapore tendente al dolce: ormai sono reperibili soltanto in alcuni villaggi montani dell’Ogliastra. C’è poi un’infinità di pani della tradizione.
Per esempio ci sono quelli che hanno la caratteristica di durare a lungo, come “su zicchi”, di fior di farina, di solito tondo come la più grossa “spianata”, o il famoso “pane carasau” alias “carta da musica” che i sardi chiamano semplicemente “sa fresa”. Fatto di farina di semola di grano duro, secco e croccante, a sottilissimi dischi sovrapposti, il pane carasau viene infornato due volte come il “pistoccu”: entrambi biscottati, accompagnano i pastori al seguito del gregge, e vengono mangiati ammorbiditi nell’acqua o nel brodo. Semola di grano anche nel “coccoi”, di forma allungata. Ma attenzione: nel Campidano così si chiamano le ciambelle allo zafferano, mentre in Gallura “lu coccu” è un pane senza lievito, cotto nella cenere rovente, e “coco” è anche una focaccia di frumento non fermentato e non setacciato, dal gusto un po’ ispido. Nel Meilogu le “coccas” sono pani votivi preparati per i Morti. “Su coccone” e “su coccoroi” sono fatti di norma col cruschello che entra in buona percentuale, unito a semola grossolana, anche nel saporito pane nero “civraxu”, specialità di Sanluri, altrove detto “civarju” o “chivarzu”. Assai più morbida la pasta del “moddizzosu” o “ammoddigadu”, una spugnosa pagnotta fatta a cupola e confezionata per onorare i Santi.
Il panorama si complica quando si passa ai pani cerimoniali e augurali, carichi di significati simbolici. Ogni patrono, festa o ricorrenza religiosa e familiare chiede il proprio, da distribuire tra amici e parenti oppure da donare agli ospiti o ai bisognosi. È allora che le massaie danno via libera al loro estro per modellarli, intagliarli e istoriarli con figure di animali, aiuole fiorite o ghirlande piuttosto che con scene di vita campestre, fino a farne delle vere e proprie sculture commestibili.
Per Capodanno forgiano il pane “candelarju”, carico di ornamenti e ghirigori, e “sos bacchiddos ‘e Deu”, a forma di piccoli bastoni episcopali: i bambini lo ricevono in cambio di una filastrocca cantata di portone in portone; le famiglie tra di loro si scambiano invece il “capude”, una schiacciata di fior di farina riservata alle grandi solennità. All’inizio dell’anno e per l’Epifania preparano anche grandi focacce di farina di frumento su cui raffigurano arnesi e personaggi legati al mestiere del padrone di casa: “sa giuada” dei contadini reca in cima un giogo di buoi e un aratro lavorati con la pasta di pane; “sa pertusitta”, un ovile con le pecore o un pastore col cane legato alla cintola.
A Pasqua si approntano pani con in mezzo un uovo, conosciuti nel Sud come “coccoieddus cun ou” o “coccoi de angùlla” e nel Nord come “cozzala dess’ou” o “di l’obu”. Ma è con i pani nuziali che le donne raggiungono l’apice creativo, plasmando i puntuti “pizzurius” o “coccoi de pizzus” campidanesi e “su pane de cojuados noos” (degli sposi novelli), “pikkadu” (intagliato) e “iskaddadu” (lucidato), come usa nel Logudoro: sottili, ricamati di merletti e resi lucenti immergendoli appena sfornati in acqua calda e poi rimettendoli in forno o spennellandoli con l’albume, hanno spesso forma di foglia, di corone, di uccelli. In alcune località vengono offerti in dono dal vicinato, decorati con pagliuzze di carta colorata e di fiori di pervinca (simbolo di felicità e di fecondità).
L’articolo Un viaggio nelle tipologie di pane in Sardegna. Un valore sociale inestimabile proviene da ogliastra.vistanet.it.